|

- Paleolitico
superiore -
Uluzziano
Il
più antico complesso italiano riferibile al Paleolitico
superiore è l'Uluzziano, così denominato dal giacimento della
Grotta del Cavallo di Baia di Uluzzo nel Salento. L'Uluzziano si
sviluppa durante l'intervallo di tempo compreso fra la fine del
Würm II-III e l'inizio dell'interstadio di Arcy. Nonostante
presenti delle affinità con il Castelperroniano (simili punte a
dorso curvo) è probabile che esso rappresenti una formazione
locale di derivazione musteriana. Mentre nei depositi della
Grotta del Cavallo è ben evidente la differenziazione tra il
Musteriano finale e l'Uluzziano, alcune industrie del Musteriano
denticolato della Toscana (rinvenimenti di superficie a Galceti,
Impruneta, S. Lucia II) presentano degli elementi
proto-uluzziani.
L'industria
litica è caratterizzata da una netta prevalenza dei
grattatoi sui bulini, da una presenza non abbondante di
strumenti a dorso e da una forte incidenza di elementi di
tradizione musteriana. Tra gli strumenti figurano le tipiche
semilune a dorso spesso, ottenute di solito con ritocco bipolare,
le microchâtelperrons (piccole punte a dorso ricurvo), i
becchi-troncatura, le troncature spesse su scheggia, i pezzi
scagliati e i raschiatoi con ritocco semierto a piccoli stacchi
lamellari paralleli ("ritocco di San Romano").
L'industria ossea comprende zagaglie cilindro-coniche di varia
tipologia e punteruoli. Nei
depositi della Grotta del Cavallo sono state distinte tre
differenti fasi: -
Uluzziano arcaico (strato E III): caratterizzato da una
forte incidenza del substrato con predominanza di raschiatoi;
abbondanti anche i pezzi scagliati e i grattatoi (di solito
frontali corti); scarse sono le punte a dorso
ricurvo e le semilune. -
Uluzziano medio o evoluto (strati E II-I): caratterizzato da
una diminuzione della frequenza del substrato e dei grattatoi
mentre aumentano i pezzi scagliati e gli strumenti a dorso (in
particolare semilune e microchâtelperrons). -
Uluzziano recente (strato D): torna ad aumentare il
substrato con prevalenza di denticolati mentre diminuiscono i
pezzi scagliati e gli strumenti a dorso; tipici sono i grattatoi
carenati e a muso e lame-raschiatoi di tipo aurignacoide.
Compaiono anche particolari oggetti di ornamento come le
conchiglie forate. In
Puglia l'Uluzziano è conosciuto anche nella Grotta di Uluzzo
(in una fase recente), nella Grotta Cosma, nella Grotta
Bernardini e nella Grotta delle Veneri; nel Gargano alla Foresta
Umbra, nel Barese a Falce del Viaggio e nel Brindisino a Torre
Testa. In Campania è stato
riconosciuto in un livello della Grotta di Castelcivita
(Salerno) compreso tra un orizzonte musteriano e uno
protoaurignaziano; in provincia di Avellino è attestato a
Tornola. In Toscana è
documentato nella Grotta La Fabbrica (Grosseto, con una
situazione stratigrafica uguale a quella di Castelcivita), a
Indicatore (Arezzo), San Romano (Pisa), Salviano e a Maroccone (Livorno).
|
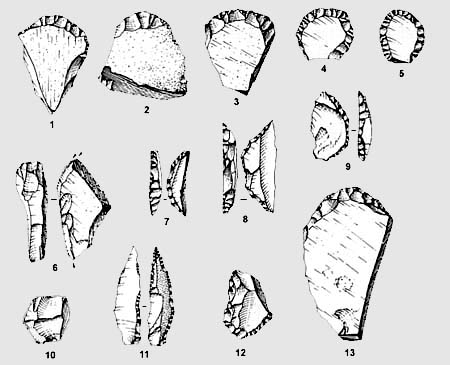
|
|
Grotta di
Uluzzo. 1-5: grattatoi, 6: bulino, 7-9: strumenti a
dorso, 10: pezzo scagliato, 11: punta, 12: scheggia
ritoccata, 13: raschiatoio (da
Broglio-Kozlowski 1986, p. 255) |
Proto-Aurignaziano Con
questo termine viene chiamato l'insieme delle industrie
aurignaziane che si sviluppa nella fase Hengelo-Arcy e che
precede cronologicamente l'Aurignaziano antico. Secondo Palma di
Cesnola si possono distinguere due facies: -
a lamelle Dufour: caratterizzata da lamelle a ritocco
marginale (10-40%), da una lieve predominanza dei bulini (ben
documentati i bulini carenati) sui grattatoi (di tipo a muso e
carenati) e da una notevole quantità di strumenti a ritocco
erto. Il Proto-Aurignaziano a lamelle Dufour deriva
probabilmente dall'Aurignaziano occidentale, in particolare dai
complessi più arcaici a lamelle Dufour della regione cantabrica
(strato 7 di Cueva Morin). E' documentata al Riparo Tagliente e
al Riparo di Fumane (Veneto), nello strato G del Riparo Mochi
(Imperia; con notevole abbondanza di lamelle a dorso marginale),
alla Vallombrosina (Firenze) e a Grotta La Fabbrica (Grosseto).
Nella Grotta di Castelcivita (Salerno) è attestato un livello a
lamelle Dufour (datato a 32930 ± 720 anni dal presente) al
quale è sovrapposto un altro livello protoaurignaziano (datato
a 31950 ± 650 anni dal presente) caratterizzato da piccole
punte a dorso marginale diretto bilaterale, simili alle punte di
Krems e a quelle di Font Yves, in associazione alle lamelle
Dufour. -
Non Dufour: caratterizzata dall'equilibrio della proporzione
bulini-grattatoi, da grattatoi carenati e dall'abbondanza di
raschiatoi, schegge ritoccate e denticolati; gli strumenti a
ritocco erto sono meno numerosi rispetto alla facies precedente,
con predominanza di troncature e becchi. In base alla presenza
di qualche strumento a dorso spesso, al substrato con
predominanza di denticolati e al ritocco tipo "San
Romano" è ipotizzabile una sua derivazione dall'Uluzziano.
E' conosciuta a Vadossi (Montalcino), a Punta Safò (Catanzaro)
e a Grotta di Serra Cicoria (Lecce). Aurignaziano
classico Questo
complesso è caratterizzato da una notevole quantità di
grattatoi (in particolare, carenati e a muso) e da lame
ritoccate. Nell'industria su osso è presente la punta a base
spaccata tipica dell'Aurignaziano I occidentale. E' conosciuto
in Liguria al Riparo Mochi (strato F), alla Grotta dei Fanciulli
(strato K) e alla Grotta del Caviglione; nel Lazio alla Grotta
del Fossellone e in Sicilia nel Riparo di Fontana
Nuova (Ragusa). L'industria della Grotta del Fossellone è
caratterizzata dall'uso di piccoli ciottoli di selce lavorati
con la tecnica bipolare; per questo motivo Blanc denominò
"Circeiano" le industrie aurignaziane di questa
grotta. Anche a Grotta Barbara, presso S. Felice Circeo, è
stata rinvenuta un' industria a piccoli ciottoli. E' probabile
che l'Aurignaziano classico derivi dall'Europa occidentale da
cui si sarebbe diffuso lungo il versante tirrenico. Parallelamente
alla facies classica si è sviluppata una tradizione locale di
origine protoaurignaziana documentata a Serino (Avellino, 31200
± 650 anni dal presente) e nella Grotta della Cala a Marina di
Camerota (Salerno, 29800 ± 870 anni dal presente).
|
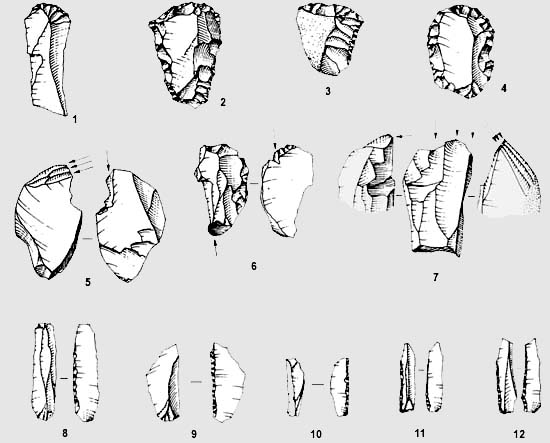
|
|
Riparo
Mochi (strato G). 1-4: grattatoi, 5-7: bulini,
8-12: lamelle Dufour (da
Broglio-Kozlowski 1986, p. 264) |
Gravettiano E'
conosciuto solamente in una fase evoluta e finale. Gravettiano
evoluto Gravettiano
a punte a dorso o indifferenziato. Industrie caratterizzate da
punte a dorso con frequenza di micogravettes e prive di
elementi specializzati; i bulini e i grattatoi sono piuttosto
scarsi. E' noto in Liguria al Riparo Mochi (strato D inferiore);
in Campania alla Grotta della Cala (strati Beta I-II) e alla
Grotta della Calanca (strato B inferiore); in Puglia alla Grotta
Paglicci (strato 22). Dal Gravettiano a punte a dorso si
differenziano dei gruppi caratterizzati dalla comparsa di tipi
speciali o dallo sviluppo di alcuni gruppi tipologici. -
Gravettiano a bulini di Noailles: noto soprattutto in
Liguria (Riparo Mochi, strato D medio e superiore), Toscana (Laterina)
e in Campania (Grotta della Cala, strato Q - Grotta della
Calanca, strato B superiore). E' caratterizzato dalla prevalenza
dei bulini (17,8-46,3%) sui grattatoi (20-21%); maggiormente
rappresentati sono i bulini su ritocco e i grattatoi frontali
lunghi. Il bulino di Noailles è frequente soltanto in Liguria e
in Toscana; in Campania è presente un tipo di bulino privo di
tacca d'arresto (para-noailles). Tra gli strumenti a
dorso prevalgono le microgravettes mentre il substrato
(in particolare, lame ritoccate) è presente in modo più
significativo soltanto in un momento finale. Le industrie del
Riparo Mochi e di Laterina presentano delle forti affinità con
la facies classica dell'Europa occidentale; è ipotizzabile
pertanto una provenienza dalla Francia del Gravettiano a bulini
di Noailles.
|
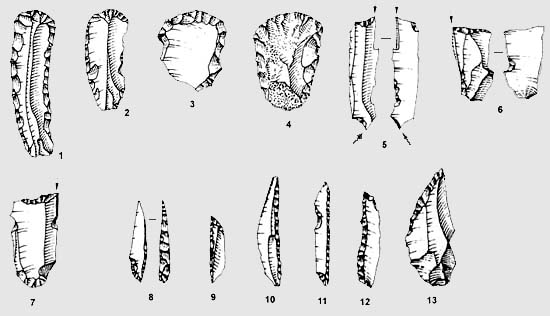
|
|
Gravettiano a bulini di
Noailles, Riparo Mochi. 1-4: grattatoi, 5-7: bulini di
Noailles, 8-10: gravette,
microgravette, 11-12: lamelle, 13: e
coltello a dorso (da
Broglio-Kozlowski 1986, p. 300) |
-
Gravettiano a rare punte di La Font Robert: documentato
nello strato 21 della Grotta Paglicci. L'industria presenta
delle analogie con le quelle dello strato sottostante ma dal
quale si differenzia per la presenza dei bulini su ritocco e per
la punta di La Font Robert. -
Gravettiano a dorsi troncati: documentato in Puglia negli
strati 20-19b della Grotta Paglicci e nello strato B della
Grotta delle Veneri (Parabita). L'industria è caratterizzata
dalla predominanza dei grattatoi sui bulini, da un progressivo
aumento dei dorsi troncati, da microgravettes e punte di
La Gravette. Gravettiano
finale -
Gravettiano finale a rari bulini di Noailles: caratterizzato
da un forte sviluppo dei bulini e dei grattatoi, scarsa presenza
di strumenti a dorso, substrato abbondante (in particolare, lame
ritoccate) e presenza di qualche punta a faccia piana di tipo
solutreano e bulini di Noailles (di dimensioni maggiori rispetto
ai tipi del Gravettiano evoluto). E' attestato in Liguria
(Grotta dei Fanciulli a Grimaldi, strato G) e in Toscana (Monte
Longo, Arezzo). -
Gravettiano finale a punte a dorso angolare: l'industria è
caratterizzata da dimensioni più ridotte rispetto a quelle del
Gravettiano evoluto, scarsa incidenza di bulini e grattatoi,
abbondante presenza di strumenti a dorso (soprattutto
microlitici) e rari pezzi foliati; particolari risultano essere
le punte a dorso angolare o ricurvo. Conosciuto nell'Italia
sud-orientale e in particolare negli strati 19a e 18b della
Grotta Paglicci sembra derivare dal Gravettiano evoluto a dorsi
troncati. Le datazioni di questa facies oscillano tra 20730 ±
290 e 20160 ± 160 anni dal presente. Epigravettiano A
differenza di ciò che accade nell'Europa occidentale i
complessi del Solutreano e del Maddaleniano non si sviluppano in
Italia. Con il termine Epigravettiano italico, pertanto, vengono
definite tutte le industrie postgravettiane originatesi dal
Gravettiano evoluto-finale sino alla fine del Tardiglaciale.
Laplace (G. Laplace, Les subdivisions du Leptolithique
italien (Etude de typologie analytique), B.P.I. 73, pp.
25-63, 1964) ha proposto una suddivisione dell'Epigravettiano in
tre fasi. Epigravettiano
antico Epigravettiano
antico a strumenti
foliati -
Epigravettiano antico iniziale:
è attestato in Puglia (Grotta Paglicci, strato 18a), in Liguria
(Riparo Mochi, strato C) e in Toscana (Aia del Colle e Gavorrano).
L'industria di questa fase presenta delle affinità con quelle
del Gravettiano finale: abbondante presenza di bulini, dei
grattatoi e del substrato, presenza di foliati (in particolare,
punte a faccia piana); le punte e le lame a dorso sono
debolmente rappresentate. Le differenze con il Gravettiano
finale consistono nella scomparsa dei bulini di Noailles e in
una maggiore incidenza dei foliati. Questa fase iniziale è
collocabile in Puglia alla fine dell'Interstadio di Laugerie. -
Epigravettiano antico a foliati: rispetto alla fase precedente i
foliati presentano una maggiore varietà tipologica. Oltre alle
punte a faccia piana le industrie sono caratterizzate da
troncature, raschiatoi foliati, grattatoi ogivali e punte a cran
a ritocco erto. E' rappresentato in Puglia (Grotta Paglicci,
strato 17 e Grotta delle Veneri), in Liguria (Caverna delle
Arene Candide, focolari 6-4), in Campania (Grotta della Cala
delle Ossa) e probabilmente nel Lazio (Cavernette Falische,
Riparo di Biedano). La struttura delle industrie varia comunque
nelle diverse aree: la percentuale dei foliati ad esempio è
più alta in Puglia rispetto al versante tirrenico. Questa fase
si sviluppa tra gli Interstadi di Laugerie e Lascaux. Epigravettiano
antico a pezzi
a cran Fase
caratterizzata dallo sviluppo degli elementi a cran e dalla
rarefazione o scomparsa dei foliati. E' attestato in Puglia
(Grotta Paglicci strati 16-10, Taurisano strati 23-6, Grotta
delle Mura), in Abruzzo (Riparo Maurizio strati 14-12, Grotta
Clemente Tronci strati H-C), nella Marche (Ponte in Pietra), in
Veneto (Grotta di Paina), in Liguria (Arene Candide focolari
3-1, Grotta dei Fanciulli focolare F), in Toscana (Poggio alla
Malva), nel Lazio (Corchiano), in Calabria (Grotta del Romito
livello 34) e in Sicilia (Canicattini Bagni, Grotta Niscemi). La
serie stratigrafica più completa è quella degli strati 16-10
della Grotta Paglicci in cui sono stati distinti tre orizzonti:
uno inferiore (strati 16-15) con forte incidenza dei crans e dei
dorsi, i bulini predominano sui grattatoi; uno medio (strati
14-12) con rarefazione dei crans, i grattatoi predominano sui
bulini, diminuzione dei dorsi; uno finale (strati 11-10) con
debole presenza dei crans, i bulini predominano sui grattatoi,
rari dorsi, sviluppo del substrato. Le principali datazioni
dell'Epigravettiano antico a pezzi a crans sono: strato 10 della
Grotta Paglicci: 15320 ± 250 anni dal presente, Taurisano tra
16050 ± 160 e 15600 ± 120 anni dal presente.
|
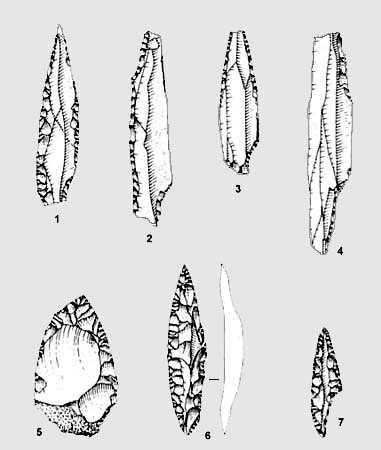
|
|
Epigravettiano
antico a pezzi a cran. Grotta di Paina, 1-4:
punte a cran. Grotta Paglicci, 5-6: punte a
faccia piana, 7: punta a cran (da
Broglio-Kozlowski 1986, p. 304) |
Epigravettiano
evoluto Non
presenta dei caratteri specifici tanto che nei momenti iniziali
è ancora simile all'Epigravettiano antico mentre in una fase
più avanzata sembra anticipare l'Epigravettiano finale. Laplace
lo ha suddiviso in due parti, una caratterizzata dal predominio
dei bulini sui grattatoi e la seconda dall'inversione del
rapporto. Successivamente è stata distinta un'ulteriore
sottofase iniziale caratterizzata da una particolare abbondanza
dei bulini. Le industrie di questa fase sono di dimensioni più
ridotte rispetto all'Epigravettiano antico e talvolta di fattura
più scadente. All'inizio persistono ancora i crans, i bulini
sono numerosi (in particolare, i tipi semplici e su frattura) e
tra i grattatoi sono prevalenti i frontali lunghi. Alla fine la
quantità dei grattatoi (in particolare, frontali corti) è
maggiore rispetto a quella dei bulini, aumentano i dorsi e, in
alcune aree, sono documentati i geometrici (in particolare,
triangoli). L' Epigravettiano evoluto è attestato in Puglia
(Grotta Paglicci strati 9-8, Riparo C delle Cipolliane strato
3), in Abruzzo (Grotta di Ciccio Felice, Riparo Maurizio), in
Liguria (Grotta dei Fanciulli focolari E-C3), in Campania
(Grotta della Cala a Marina di Camerota), nel Lazio (Palidoro
strato B, Cenciano Diruto strati II-I, Riparo di Biedano strati
IV-III) e in Sicilia (San Corrado). Epigravettiano
finale In
questa fase si sviluppano dei complessi a diffusione regionale
che si differenziano notevolmente fra loro. I caratteri comuni
sono: aumento dei grattatoi (in particolare, frontali corti,
unguiformi, circolari e semicircolari), regresso qualitativo e
quantitativo dei bulini, frequenza delle punte a dorso ricurve,
diminuzione di gravettes e microgravettes,
sviluppo dei dorsi troncati e talvolta dei geometrici (in
particolare, segmenti, triangoli e trapezi), diffusione del
microbulino e del microlitismo, minore indice di laminarità.
Sono state individuate cinque principali aree: medio a altro
Adriatico (Riparo Tagliente-Verona, Piancavallo-Pordenone,
Viotte e Andalo-Trento, Grotta della Ferrovia e Grotta del
Prete-Ancona), versante sud-orientale (Puglia: Riparo Paglicci
strati 7-1, Grotta delle Mura, Grotta di Santa Croce, Riparo C
delle Cipolliane, Taurisano, Bocca Cesira, Ponte Zecca, Grotta
Romanelli), versante alto-tirrenico (Liguria: Grotta dei
Fanciulli focolari D-C, Riparo Mochi strato A, Arene Candide
strati C III-I, Arma dello Stefanin, Arma di Nasino. Toscana:
Grotta delle Campane, Isola Santa strato 5), versante medio e
basso tirrenico (Campania: Grotta della Cala strati L-F, Grotta
Erica, Grotta La Porta, Grotta del Mezzogiorno. Lazio: Grotta
Polesini strati 12-1, Riparo Biedano strato I, Riparo Salvini,
Grotta Jolanda, Peschio Ranaro. Sicilia: Grotta dell'Acqua
Fitusa, Grotta di San Teodoro, Grotta di Levanzo). Negli
strati E-A della Grotta Romanelli è stata riconosciuta una
facies denominata "Romanelliano". E' distinta in due
fasi: una con maggiore quantità di dorsi troncati e
dall'abbondanza di punte, l'altra caratterizzata da un notevole
sviluppo dei grattatoi, in particolare dei tipi circolari. Le
datazioni assolute oscillano fra 10640 ± 100 e 9880 ± 100 anni
dal presente. Una fase terminale del Romanelliano di età
olocenica, denominata "Epiromanelliano", è stata
individuata nella Grotta del Cavallo, nello strato 1 del Riparo
C della Cipolliane, nella Grotta di Uluzzo, nello strato C della
Grotta delle Prazziche e nello strato A della Grotta-Riparo C.
Cosma. Questa fase è caratterizzata da frammenti semilunari di
conchiglie di Pectunculus.
Fonte:
Broglio
A. - Kozlowski J., Il Paleolitico – Uomo, ambiente e
culture, Jaca Book, Milano 1986
, pp. 268, 298-305
Cocchi
Genik D., Manuale di Preistoria, Paleolitico e
Mesolitico, volume I, Octavo, Firenze 1994
, pp. 191-215
 |
 |
| Cronologia-Sommario |
Sommario |
|